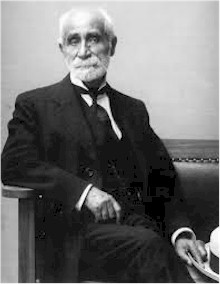|
Sempre verso la fine
dell’Ottocento, Pitrč, con l’aiuto di
Salvatore Salomone Marino,
editņ una rivista specializzata nel settore etnografico, intitolata
Archivio per lo studio delle tradizioni
popolari.
La diresse dal
1880 al 1906.
Col passare del tempo, crebbe la sua importanza ed i suoi meriti.
Arrivarono, cosģ, le prime nomine ed i primi onori.
Se nel 1894, Pitrč con la pubblicazione
della Bibliografia delle
tradizioni popolari d'Italia, fu premiato dalla Reale
accademia delle scienze di Torino,
nel 1903, fu nominato Presidente della Reale Accademia di Scienze e Lettere di
Palermo e nel 1909,
divenne
socio dell'Accademia della Crusca.
Fu, anche, presidente della Societą siciliana di storia patria. Nel 1910, fu chiamato a ricoprire la cattedra di
demopsicologia (cioč il folclore),
all’Universitą di Palermo. Ma non basta, perché, due anni prima
della sua morte (1914), Giuseppe Pitrč fu nominato Senatore
del Regno d’Italia.
Mentre
raccoglieva informazioni, Pitrč instaurņ rapporti epistolari con
numerosi studiosi sparsi per il mondo. Tale corrispondenza č oggi
conservata nel museo
etnografico di Palermo.
Tale museo fu fondato dallo stesso Pitrč nel 1910. In esso egli
raccolse tutto il materiale informativo e gli oggetti pazientemente
raccolti in tutta la Sicilia. Il museo č oggi collocato nelle
ex-stalle della Palazzina Cinese, che si trova all'interno del Parco
della Favorita di Palermo.
Negli anni di studi e ricerche, Giuseppe Pitrč
ampliņ la sua opera, non solo come bacino antropologico (pubblicņ,
nel 1894, il trattato
Bibliografia delle tradizioni popolari in Italia),
ma anche testi letterari, quali
Palermo cento e pił
anni fa, e
libri su Goethe (che visitņ Palermo e la Sicilia),e sulla stessa
Divina Commedia. Oltre
a questi libri, egli realizzņ inoltre testi riguardanti
studi storici e filologici.
L’amico Salvatore
Salomóne Marino
Salvatore Salomóne
Marino, come il Pitrč, era un medico palermitano, che, pubblicņ, nel
1867, il suo primo testo di
canti popolari. Ricercatore etnografico, nonostante la pubblicazione
di diversi trattati, č oggi conosciuto soprattutto per
“La baronessa di Carini”. Al suo interno, oltre ad
un poemetto del XVI secolo sulla baronessa, scritto in siciliano,
egli riportņ i numerosi documenti ritrovati sull’accaduto.
L’uccisione da parte del padre della baronessa, viene rivissuto
direttamente sui testi del successivo processo (secondo il diritto
spagnolo), che scagionņ il genitore.
|