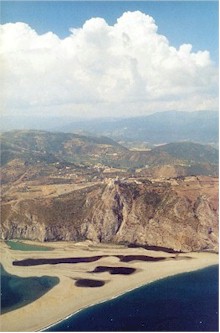Nell’area dei Nebrodi
sarebbe meno problematico che altrove promuovere una coscienza collettiva avanzata
rispetto alla gestione urbanistica e ambientale. E questo perché l’uomo dei Nebrodi,
fortemente determinato, è sempre riuscito a sanare le ferite delle dominazioni e delle
occupazioni e a ricostruire sulle sistematiche distruzioni dei boschi che si sono
succedute sin dall’epoca dei fenici.
A questa costante storica - già di per sé
importante base per una moderna cultura dell’ambiente - si aggiunge oggi la
straordinaria occasione della costituzione del Parco naturale. Una legislazione più
illuminata può fare il resto, accompagnando la normativa vincolistica con
un’incentivazione in termini di contributi, mutui, sgravi fiscali. Questo è il modo
più giusto ed efficace per avviare un’opera di risanamento e di conservazione delle
colture agricole e boschive, del risanamento urbano anche attraverso l’utilizzazione
dei materiali edilizi tradizionali. La gente dei Nebrodi sente fortemente l’esigenza
della tutela della propria identità, nella quale giustamente include i luoghi e le
tradizioni. L’istituzione del Parco dei Nebrodi, inoltre, potrebbe fornire
un’occasione non facilmente ripetibile per promuovere una robusta campagna di
educazione ambientale, rivolta al recupero complessivo di tutte le potenzialità
dell’intera area.
L’istituzione del Parco,
comunque, va collocata in una prospettiva più ampia: non di mera conservazione, ma di sviluppo delle aree
boschive. L’estensione delle foreste per contrastare la riduzione dell’ossigeno
e il surriscaldamento dell’atmosfera terrestre è ormai una vera e propria emergenza
della nostra epoca. Una emergenza che non va affrontata soltanto in Amazzonia o nel
Camerun difendendo il patrimonio ecologico esistente, ma va fronteggiata anche nei paesi
ad alto sviluppo: anche in Europa, dunque, e qui da noi in Sicilia, sulle colline e sulle
montagne.
Ma anche in questo caso sarà
necessario uscire dai pigri binari degli interventi tradizionali e studiare una strategia
articolata che preveda l’impiego di tecnologie avanzate sul terreno della protezione
preventiva degli incendi, l’assunzione di personale specializzato per la salvaguardia
del verde, il coinvolgimento (con incentivi adeguati) dell’iniziativa privata nella
riforestazione, in parte da destinare a zone protette di habitat naturale da
ricostruire, programmando taglio e successiva ricostituzione. Una strategia di questo
tipo, oltre a migliorare l’ambiente e le stesse condizioni climatiche, aprirebbe
spazi interessanti all’occupazione giovanile.
Dobbiamo smetterla di
considerare l’ecologia e la tutela dei centri storici e del territorio come velleità
utopiche e cominciare ad abituarci ad assumerli come parametri obbligati delle nostre
azioni quotidiane e della nostra volontà progettuale. Così anche i conti complessivi
dell’economia torneranno meglio.
Nell’area dei Nebrodi
esistono tutte le condizioni per sperimentare una programmazione avanzata degli interventi
sul territorio che sappia andare oltre la difficile mediazione tra sviluppo economico e
conservazione ambientale.
Il punto di partenza, infatti,
è ancora più che soddisfacente, perché i Nebrodi non sono stati investiti, se non
marginalmente, da quel tipo di crescita dissennata delle attività economiche che ha
travolto molto spesso gli equilibri ambientali, cancellando anche interi complessi
paesistici e monumentali.
Favorisce una simile
prospettiva il fattore umano che qui è particolarmente sensibile ad un messaggio di
questo tipo.
Per secoli la gente dei
Nebrodi ha difeso contro gli invasori stranieri le proprie tradizioni e, nella misura del
possibile, il proprio ambiente, riuscendo ad omologare - invece che arrendersi
all’egemonia culturale - etnie diverse discese dal nord più evoluto: svevi,
normanni, monferrini e lombardi, sopratutto quei lombardi di cui Elio Vittorini in
"Conversazione in Sicilia" ha ricercato l’esistenza oltre i confini di San
Fratello, dove l’impatto è stato più forte, lasciando segni persino a livello
linguistico. Può farlo ancora, può ripristinare quell’habitat unico, che il mito
greco assegnava alla cacciatrice Artemide.
È dunque su questi cardini
che va costruito il futuro di quest’area: un futuro che non rinneghi le proprie
radici, ma impianti su di esse più saldamente prospettive e speranze.