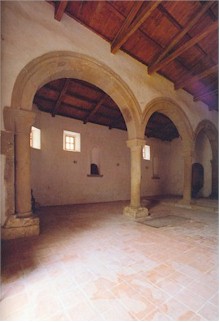LE FAGGETE
Quasi senza interruzioni occupano
l’intero crinale dei Nebrodi da Monte Tre Arie (Comuni di Tortorici e Randazzo) a
Monte Castelli (Mistretta), con una formidabile "fuga" di oltre 40 km.
Due grossi nuclei hanno perso contatto da
questa vasta area di vegetazione: la Faggeta di Malabotta (Tripi e Montalbano E.) ad
Oriente, e quella di Monte Sambuchetti (Nicosia) dalla parte opposta; oltre a piccoli
nuclei sparsi nei Comuni di Floresta, Randazzo e Tortorici.
L’area di vegetazione si è
progressivamente contratta nel tempo. La faggeta, infatti, come un esercito in ritirata,
ha dovuto cedere posizioni fino a trovarsi oggi a difendere le ultime
"roccheforti" residue: le alture dei Nebrodi, alcuni contrafforti delle Madonie
e una piccola porzione dell’Etna.
Il faggio in Sicilia non c’è stato da
sempre; vi è arrivato, unitamente ad altre specie tra cui l’abete bianco, muovendo
dall’Europa centro-settentrionale, sua dimora abituale, durante le glaciazioni,
quando il clima, da caldo-arido qual’era, divenne freddo umido, e tale rimase per
diverse migliaia di anni. Per tutto quel periodo il faggio e l’abete ricoprirono
l’intera catena montuosa settentrionale della Sicilia.
Allo stato attuale, oltre l’85 per
cento delle faggete di Sicilia (10.000 ha circa contro i 13.000 complessivi) si trova sui
Nebrodi, in prevalenza sul versante esposto a tramontana, dove può scendere fino a
1.100-1.050 metri di quota con punte di 1.000 metri sotto forma di piante sparse, come a
Mistretta.
Tra i complessi meglio conservati e di
maggiore pregio, anche estetico, meritano una citazione particolare i boschi di Cartolari
(Tortorici), Foresta Vecchia (Bronte), Mangalaviti (Longi), Monte Soro e Sollazzo Verde
(Cesarò), Dugo e S. Antonio (Capizzi), Moglia (Caronia), Medda (Mistretta). Il complesso
più esteso è quello che gravita attorno a Monte Soro.
Verso i limiti superiori della sua area di
vegetazione, il faggio vive "in splendida solitudine" e mal sopporta la presenza
di elementi estranei. Molte altre essenze penetrano dentro la faggeta: il cerro, il
leccio, la roverella, l’olmo di monte, il frassino maggiore, l’opalo, il sorbo
selvatico, il sorbo degli uccellatori, il tiglio, il tasso, l’agrifoglio. Negli
ambienti umidi e lungo i corsi d’acqua fanno apparizione l’ontano nero, la
carpinella, la "berretta del prete" (evonymus europea), diversi salici.
Tra le specie erbacee presenti, molte sono
considerate di grande valore ecologico: l’erba laurina, un piccolo arbusto portante
in cima una rosetta di foglie spesse e lucenti; l’anèmone apennina, deliziosa
pianticella con fiori solitari e petali raggiati di colore blu porporino; il doronicum
autunnale, inconfondibile per i suoi capolini gialli, solitari, portati in vetta a
steli esili e leggermente ricurvi; la peonia officinalis, bellissima con i suoi
fiori grandi colorati di porpora recanti al centro centinaia di filamenti gialli, la scilla
bifolia dai vistosi fiorellini azzurri riuniti a mazzetto; il cynoglossum creticum,
dalle caratteristiche foglie larghe e morbide di colore grigio, fiori piccoli bluastri e
frutticini finemente spinosi; la mercurialis perennis, pianticella propria dei
luoghi freschi, dalle spighette verdastre erette; la luzula sicula, simile alle
graminacee, con foglie piene cosparse di lunghi peli bianchi; il sambucus racemosa,
con fiori in dense infiorescenze bianche terminali e numerosi frutti rossi splendenti.
Di tutte le piante che partecipano al
corteggio floristico del faggio, il più "illustre" è senz’altro il tasso,
presente in Sicilia solo sui Nebrodi, noto anche come l’albero della morte perché
tossico in ogni sua parte (diversi animali ogni anno muoiono per avere ingerito poche
foglie), ad eccezione dell’arillo carnoso rosso-intenso, di bell’effetto, che
dagli uccelli viene infatti attivamente ricercato. Specie antichissima (si fa risalire
all’Era terziaria), è anche tra le più longeve della nostra flora, riuscendo a
vivere fino a 2000 anni ed oltre. All’epoca della fruttificazione non si può
confondere con nessun’altra pianta, ma in altro periodo dell’anno un occhio poco
allenato la può scambiare per un abete, a motivo della sua forma largamente piramidale,
le foglioline piatte attaccate ai rami su due file, la corteccia bruno-rossastra che si
sfalda a fogli.
Molte essenze si impongono
all’attenzione per il grande effetto decorativo, soprattutto quando sono in fiore o
maturano il frutto. |