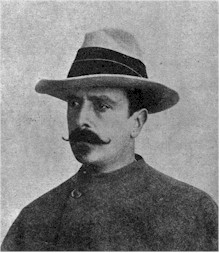|
Il nome per esteso di Paolo Orsi,
risulta all’anagrafe come
Pietro Paolo Giorgio Orsi,
nato e morto a Rovereto, in provincia di Trento (Trentino-Alto
Adige). Nonostante che il suo nome si sia legato alle innumerevoli scoperte
fatte in Sicilia e Calabria, nella prima parte della sua vita studiт
e operт in alta Italia.
Nato a Rovereto, come detto, essendo la
cittadina facente parte dell’impero Austroungarico, la sua
formazione fu mitteleuropea. Dopo gli studi liceali, infatti, si
spostт a Vienna dove si iscrisse a
corsi di storia antica e archeologia. Successivamente proseguм gli
studi all'Universitа di Padova e poi Roma, dove si laureт. Non
soddisfatto, mise a punto la sua formazione da archeologo,
specializzandosi con corsi presso
la
scuola d'arte classica a
Bologna, la Reale
scuola italiana di Archeologia e quella di paleontologia,
ambedue a Roma.
La sua cultura e le sue qualitа gli
ritagliarono, sin dall’inizio, un ruolo dirigenziale. Dopo una breve
esperienza, come professore al liceo di Alatri (Roma), riuscм ad
entrare nella direzione generale delle antichitа e delle belle arti
dopo di chи operт anche alla Biblioteca nazionale centrale di
Firenze. Ciononostante, essendo il suo sogno quello di insegnare
all’universitа, partecipт ad un concorso all'Universitа di Roma (per
la cattedra di archeologia). L’esito fu negativo. A questo
punto Orsi, come ripiego, proseguм come ispettore statale degli
scavi e dei Musei.
La sua vita, perт,
stava per prendere una nuova felice piega. Avendo giа fatto
precedentemente un’esperienza sul campo nel
Trentino, dove aveva
riportato alla luce a Mori la zona preistorica, detta del
Colombo, nel 1890, fu mandato per delle ricerche a Siracusa.
Velocemente prese conoscenza dell’antica storia e della cultura dei
Sicani e dei Siculi, primi abitatori della Sicilia. Forte di queste
informazioni, si mise al lavoro per degli scavi nella provincia di
Siracusa, ma, piщ in generale, nell’area dei monti Iblei, nella zona
sud-orientale dell’isola.
Oltre alla necropoli di Pantalica (ed altre), individuт
piccoli centri dell'etа del
Bronzo, Thapsos ma
anche antiche polis greche, come Naxos, Casmene e Megara Hyblaea.
Con un lavoro duro, Paolo Orsi scoprм necropoli, templi,
mura, palazzi, statue, ceramiche e monete.
Dopo tali successi,
dal 1900 al 1901, fu nominato Commissario del Museo Nazionale di
Napoli. Nel breve tempo, riordinт i reperti contenutivi, creando con
essi dieci grandi raccolte di materiali. Ai suoi successori
lasciт questo impegno da realizzare.
La sua esperienza
sulle aree meridionali e la loro storia, gli valse, nel 1907, la
nomina alla Soprintendenza della Calabria, con uffici a
Reggio Calabria, dove
si trasferм. Qui diede vita al Museo Nazionale della Magna Grecia,
operando, con ricerche e scavi, in molte zone calabresi, come Vibo
Valentia, Locri, Crotone, Sibari, Rosarno e la stessa Reggio. Molti
furono i ritrovamenti, anche in Calabria, riportando alla luce
antiche cittа della Magna Grecia, quali Medma, Krimisa e Kaulon.
Nel 1909, creт con
altri la Societа Italiana di Archeologia.
Dopo la nomina di un
nuovo soprintendente capo, avvenuta nel 1924, Orsi lasciт Reggio per
trasferirsi a Siracusa. In questo periodo gli fu offerta una
cattedra universitaria (il suo vecchio sogno). Rifiutт,
concentrandosi sull’attivitа pratica. Nella cittа siciliana,
infatti, collaborт alla risistemazione del locale museo
archeologico.
La considerazione di cui godeva era tale, che in
questo stesso anno, fu
nominato senatore del
Regno d'Italia.
Sui suoi ritrovamenti in Calabria e Basilicata,
fondт, nel 1931, una rivista specifica di storia antica (“Archivio
storico per la Calabria e la Lucania”).
Morм a Rovereto nel
1935.
Di lui il suo collega e amico,
Enrico Gagliardi, ha scritto: “Dovunque
egli и passato, ha lasciato un'orma profonda”. Ed in effetti, per
vedere il suo
lavoro basta visitare il Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia
di Reggio Calabria ed il Museo Archeologico di Siracusa, in cui sono
conservati gli innumerevoli reperti da lui scoperti.
Nella sua
vita Paolo Orsi scrisse oltre 300 saggi di argomenti diversi, sempre
nel campo dell’archeologia. Per tale instancabile opera ottenne
il Gran Premio di
Archeologia dell'Accademia dei Lincei, tra i massimi
riconoscimenti dell’epoca.
Il Museo archeologico
di Siracusa oggi porta il suo nome.
|